La Trilogia
- Mirko Agliardi
- 13 gen 2020
- Tempo di lettura: 4 min

Il Santo, il Giovane, la Saggezza (Trilogia; Fontana della vita)
1912
marmo di Candoglia; 268 x 250 x 120 cm
Milano, Galleria d'Arte Moderna,dono eredi Rose, 1913
A partire dal 1902 Wildt iniziò a lavorare a una fontana da interno con tre figure in marmo per un padiglione apposito da erigersi nel parco del castello di Dölhau, con vetrate colorate disegnate da Huber Feldkirch e pareti rivestite di velluto. La prima versione dell'opera era il gruppo in gesso dei "Beventi", presentato con molte aspettative all'Esposizione Internazionale di Milano nel 1906: le critiche ricevute e l'insoddisfazione per l'opera indussero Wildt a distruggerla e lo gettarono, secondo il suo racconto, in una crisi che durò tre anni. L'opera è nota solo da fotografie,così come anche un bozzetto in gesso con il pavone davanti alle figure, poi eliminato, già in collezione Rose. Da un bozzetto in gesso del 1908, in cui il pavone è spostato a rilievo sul fondo dietro la Saggezza, venne tratta nel 1929 la fusione in bronzo donata alla Galleria d'Arte Moderna di Milano da Leo Goldschmied, committente del Parsifal. Un 'altra fotografia riproduce la prima versione della figura del Saggio (A.Bucci 1919). "Subito dopo l'Autoritratto,da due blocchi di marmo da 290 quintali,incominciai a trarre la mia Trilogia. Per la verità vi dirò che nessuno scultore al mondo osò mai affrontare 290 quintali di marmo": Wildt riprese il lavoro nel 1908, e continuò fino al 1912 con continui cambiamenti,lavorando "infaticabilmente"di giorno e rifinendo il marmo di notte, a lume di candela. Stando al libro dei conti dello studio,dal novembre del 1908 al marzo successivo lavorò alla figura del Santo, iniziando in aprile la parete di fondo, che attesta a quell'anno uno stadio complessivo della lavorazione del marmo molto avanzato; infine modificò la posizione delle braccia del Giovane al centro; ruotando il braccio sinistro dietro la schiena e sostituendo il destro, avvolto in un drappo,nel luglio del 1911. A conferma del valore affidato a questo dettaglio, il braccio fu fatto fotografare a Emilio Sommariva, prima di essere assemblato alla figura. Terminato nel 1912,il marmo fu esposto alla Triennale di Brera, sul suo basamento in bronzo,circondato da tendaggi al centro di un padiglione appositamente allestito nel giardino del palazzo della Permanente, conquistandosi - non senza discussioni - il premio Principe Umberto, con l'approvazione di Leonardo Bazzaro, Enrico Butti e Gaetano Previati e il solo voto contrario di Filippo Carcano. Costato a Rose cento cinquantamila marchi,il marmo era ancora a Milano quando questo morì nel dicembre 1912. Ereditato dal fratello Carl,fu inviato a spese della famiglia al Glaspalast di Monaco nel 1913,dove venne proposto dalla Commissione Italiana per la medaglia d'oro per la scultura. Incontrò però l'incomprensione degli scultori- e l'apprezzamento dei pittori- come riportato da Gerolamo Cairati, commissario dell'Italia all'esposizione,con cui Wildt intrattenne un fitto carteggio: "Non ebbi dai citati signori, della commissione, nemmeno un voto favorevole. La cosa mi addolorò assai, ma non mi meravigliò, poiché fin da quando il gruppo si stava mettendo a posto potei notare chiaramente che quasi tutti indistintamente gli scultori erano avversi alla sua colossale opera, pur non potendone disconoscere la fenomenale abilità di fattura. Nella massima parte dei pittori trovai invece sentimenti opposti, molti anzi entusiasti"(lettera di Cairati a Wildt del 12 giugno 1913). L'opera fu quindi richiesta dalla Società Scultori di Vienna per l'esposizione d'autunno,dove non fu inviata perché la famiglia Rose era in trattative con il museo di Zurigo. Infine fu donata da Carl von Rose al comune di Milano,che stentò non poco a trovarle una collocazione. Il sindaco Emanuele Greppi stanziò una somma perché l'opera fosse sistemata,d'accordo con Wildt, all'ingresso dell'allora nascente Città degli Studi: il gruppo avrebbe dovuto essere collocato sulla facciata dell'erigenda nuova sede dell'Accademia di Belle Arti. Intanto il gruppo, smontato e sistemato in cinque casse,venne alloggiato nei sotterranei dell'Arena Civica. Dopo la fine della guerra venne ricomposto per l'Esposizione Regionale Lombarda di Arte Decorativa del 1919,addossato alla parete di fondo di uno dei cortili dell'Umanitaria,coperta di rampicanti come una "spalliera di edere e convolvoli": "Scende l'acqua a stillicidio,continua,sgorga dal muschio fresco e gelatinoso come da sorgente montanina: e la mano del Giovane in marmo leggermente rosato,levigato finemente,sotto la trasparenza dell'acqua,per riflesso d'un raggio di sole che la carezza in pieno,acquista una verità e morbidezza impressionante di carne che palpiti e viva"(Caretta 1919). Si inaugurava così un lungo periodo di conservazione all'aperto che ne pregiudicava la conservazione: il gruppo restò infatti nel cortile fino al 1925, suscitando le proteste di Giuseppe Chierichetti. Questi aveva ottenuto da Guido Marangoni la promessa di una collocazione alla Villa Reale, sede della Galleria d'Arte Moderna, dove infatti venne sistemata nel 1926 in una macchia d'alberi nei giardini, pudicamente censurata con foglie di fico, sotto una struttura in calcestruzzo aperta su tre lati, che non poté evitare ulteriori offese,tanto da costringere negli anni ottanta la chiusura con lastre di vetro. Intaccata e usurata, la superficie del marmo ha perso le dorature, la cui presenza è attestata dal libro dei conti di Wildt, e l'originaria levigatezza. Destinata a rimanere una delle sculture più note dello scultore, l'opera segnò il suo ingresso nel panorama artistico italiano, dopo quasi vent'anni di lavoro in esclusiva relazione con l'ambiente nordico,tanto che al suo apparire fu considerata la sorprendente opera d'esordio di un giovane tedesco. Sconcertarono il muoversi tea astrazioni e verità anatomiche,tea medioevo ascetico e rigoglio barocco,il classicismo professato come fede ma scosso da forzature espressioniste, la concezione "ultra montana, per non dire oscura o macabra", il riferimento a Rodin e l'approdo a Michelangelo, ma anche l'abilità dell'intaglio nel durissimo marmo di Candoglia: "Polemiche, esaltazioni, ingiurie, corse anche qualche pugno nelle sale dell'Esposizione. Chiusa in un chiosco nel parco di Villa Reale, riservato ai bambini e vietati agli adulti, la "Trilogia"oggi non solo è quasi invisibile, ma nell'insieme anche infotografabile per i riflessi dei vetri aggiunti a protezione. A parte la fotografia storica di Emilio Sommariva, l'opera può essere documentata pertanto solo in qualche particolare,con riprese molto ravvicinate dall'interno del chiosco.
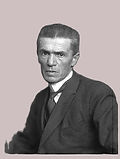





Commenti